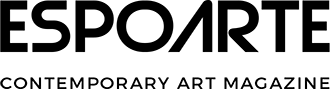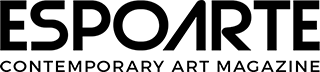MILANO | Pinacoteca di Brera | 10 novembre 2016 – 5 febbraio 2017
La Pinacoteca di Brera di Milano apre domani al pubblico – con Attorno a Caravaggio – il Terzo dialogo che, dopo il successo di quelli dedicati a Raffaello e Perugino e Mantegna e Carracci, rimette a confronto un capolavoro delle sue collezioni con altre eccezionali opere provenienti da istituzioni e collezioni internazionali ed accolte come “ospiti” nelle sale della pinacoteca milanese.
La Cena in Emmaus di Caravaggio, uno dei quadri più celebri conservato a Brera, è il protagonista di questo evento e, per l’occasione, contemporaneamente al previsto riallestimento di sette sale della Pinacoteca, viene sistemato in una nuova posizione che, grazie ad un impatto più scenografico, riesce ad esaltare le sue straordinarie caratteristiche chiaroscurali.

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Cena in Emmaus, 1606, olio su tela, 141×175 cm, Pinacoteca di Brera, Milano
Dipinto dal maestro – in uno dei momenti maggiormente drammatici della sua tormentata esistenza – durante la fuga da Roma del 1606, la tela mostra un’essenzialità e una rapidità esecutiva insolite nella produzione precedente. Qui le stesure pittoriche – a volte traspaiono particolari appena abbozzati – diventano esempio iniziale della tarda pittura di Caravaggio, la quale si farà sempre più sofferta ed “esistenziale” nella visione e nella concezione delle immagini.
Attorno a Caravaggio, sotto la regia curatoriale di Nicola Spinosa, segue una serie di comparazioni che riunisce per la prima volta dipinti – anche affini per soggetto – che spingono a nuove verifiche e nuove letture scientifiche questi capolavori: la proposta del confronto reciproco s’inquadra proprio nel desiderio di rendere la visita alla Pinacoteca un momento laboratoriale e di sperimentazione, di scambio, aggiornamento e ricerca, con il duplice scopo di soddisfare le esigenze degli studiosi e di stimolare la comprensione e la partecipazione del grande pubblico.
Alla Cena in Emmaus si accompagnano, quindi, cinque dipinti con alcune attribuzioni a Caravaggio – attribuzioni variamente accolte, contestate o attribuiti ad autori suoi contemporanei – che attestano la diffusione e l’apprezzamento dello stile caravaggesco, tanto nuovo quanto radicale, nel panorama europeo: sono esposte a Brera la controversa Giuditta che decapita Oloferne (opera di collezione privata ritrovata nel 2014 in una soffitta di una casa di Tolosa) che si accompagna alla Giuditta della collezioni delle Gallerie d’Italia assegnata al fiammingo Louis Finson. Il Dialogo prosegue con la Maddalena in estasi del Musée des Beau Arts di Marsiglia, sempre di Finson, che trova reciprocità del medesimo soggetto nell’opera proveniente dalla Collezione Paolo Volponi. Quest’ultima è una delle otto copie di vari artisti che, secondo le fonti, si sono basati sull’originale – non trovato – che Caravaggio aveva realizzato nello stesso periodo della Cena in Emmaus. Conclude il percorso il Sansone e Dalila, terzo dipinto di Finson e sempre proveniente dal museo di Marsiglia, considerato tra i suoi capolavori assoluti.

Terzo dialogo. “Attorno a Caravaggio”, veduta della mostra, Pinacoteca di Brera, Milano
Le opere coinvolte aprono aspetti interessanti di riflessione sul tema importante e dibattuto quale l’attribuzione dell’opera d’arte e degli studi che sottendono la scoperte di opere inedite le cui ricerche che proseguono anche quando i dipinti entrano nelle prestigiose collezioni di musei internazionali. La scelta del Dialogo va proprio in questa direzione di “verifica”, osservazione e studio, fornendo a tutti l’occasione per vedere opere accostate, nello stesso imperdibile momento, le une alle altre.
Le opere caravaggesche – e non – esposte aprono anche considerazioni sui temi religiosi che si inseriscono nei nuovi principi estetici e iconografici dettati dal nuovo canone della Controriforma cattolica, allora da poco confermata dal Concilio di Trento.
Attorno a Caravaggio chiude un anno importante per Brera che, sul solco tracciato dal direttore James Bradburne, sta lentamente rinnovando il modo di vivere i propri tesori secondo l’idea del “museo vivo”, missione mossa dal soprintendente Franco Russoli già nei primi anni Settanta.
Afferma lo stesso Bradburne:
“Le installazioni museali devono cambiare per continuare a ‘rimettere in scena’ la collezione, nello stesso modo in cui Verdi viene rimesso in scena ogni anno alla Scala. Un museo che non crede più alla propria collezione, ha perduto la via. Ma la collezione da sola non basta: il visitatore deve essere preparato a farne esperienza e quindi attorno all’opera d’arte si deve creare una forte carica emotiva. Questo avviene quando il visitatore impiega in modo attivo la propria mente per entrare nell’opera, per esaminarne i dettagli, per esplorarne le immagini, per farsi commuovere dalla tecnica o dal significato, e per condividere le proprie emozioni con gli altri. Se un visitatore è distratto da una pessima illuminazione, disturbato da personale scortese, offeso da didascalie illeggibili e incomprensibili, è improbabile che si trovi nello stato d’animo ricettivo necessario a entrare con l’immaginazione in un’opera d’arte, e portar via con sé anche solo una parte di ciò che l’artista vi ha infuso. È questa capacità di immaginare i bisogni di ogni visitatore potenziale, e di prepararlo ad accettare il piacere a volte difficile di misurarsi in prima persona con l’arte, che fa la differenza tra quella che è solo una grande collezione e un museo davvero grande.”

Louis Finson, Giuditta che decapita Oloferne, 1607 circa, olio su tela, 140×161 cm, Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d’Italia, Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli
Per questo Dialogo sono state riallestite sette sale (per un totale di 20 nel 2016) dell’ala meridionale della Pinacoteca, comprendendo quelle dei Manieristi (27), Tra naturalismo e classicismo da Annibale Carracci a Caravaggio (28), Il naturalismo: i pittori romani e napoletani dopo Caravaggio (29), Il Seicento Lombardo (30), Rubens: dal pittoricismo al barocco (31), I ritratti (32), Natura in posa (33). Questo progetto di sistemazione delle sale, in tre anni, coinvolgerà l’intero museo.
Per la giornata dell’inaugurazione l’ingresso della Pinacoteca sarà gratuito.
Terzo Dialogo. Attorno a Caravaggio
a cura di Nicola Spinosa
con prestiti di Musée des Beaux-Arts, Marseille; Banca Intesa Sanpaolo; due collezioni private
allestimento sale XXVII-XXXIII Francesca Debolini, Letizia Lodi, Maria Cristina Passoni, Cristina Quattrini, Nicola Spinosa
progetto e direzione dell’allestimento James M. Bradburne, Alessandra Quarto, Angelo Rossi
10 novembre 2016 – 5 febbraio 2017
Sala 28
Pinacoteca di Brera
via Brera 28, Milano
Orari: da martedì a domenica 8.30-19.15 (chiusura biglietteria 18.40); il giovedì 8.30-22.15 (chiusura biglietteria 21.40); chiuso lunedì
Ingresso intero €10.00; ridotto €7.00; gratuito ogni prima domenica del mese
Info: www.pinacotecabrera.org